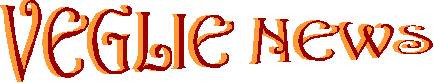
|
|
|
Dal Messaggero di Mercoledì 19 febbraio 2003 - articolo di Raffaele Simone* A lezione di virgole da Totò e Peppino «Come voi ben sapete. Punto. Punto. Due punti. Ma sì! Fai a vedé che abbondiamo! Abbondandis abbondandum!» Così Totò, nella famosa scena di Totò, Peppino e la malafemmina, detta a Peppino la lettera che dovrebbe liberare il nipote dalla "malafemmina". Di quella scena abbiamo riso tutti ma, per quanto riguarda la punteggiatura, il nostro stato non è molto migliore. Ora ce lo ricorda Ornella Castellani Pollidori, una eccellente studiosa di storia dell'italiano, in un suo articolo pieno di allarme. Gli italiani non sanno più mettere la punteggiatura, e in particolare le virgole. Un segnale tra tutti. I giornalisti hanno fatto ormai piazza pulita di una virgola obbligatoria, quella che separa il vocativo dal seguito del discorso. Quando intervistano una persona, non scrivono (come dovrebbero): «Onorevole, ci direbbe che ne pensa di...», ma più semplicemente: «Onorevole ci direbbe che ne pensa di...». Scomparsi i due punti, il punto e virgola, le virgolette, rimane quasi solo (specie nell'uso dei giovani) la virgola, per lo più messa a sproposito, e qualche punto vagante. Non parliamo dell'a capo, che quasi nessuno ormai sa più dove va messo. A parziale scusante di questo terremoto c'e il fatto che il sistema interpuntivo è una cosa molto complicata. Non a caso è un'invenzione tarda. Gli antichi non avevano nessun segno di punteggiatura vero e proprio. La virgola sembra sia stata inventata nel Quattrocento, quando era ancora chiamata "sospiro", alludendo alla pausa di fiato che comporta. Lo sviluppo della stampa dette il contributo decisivo. Le virgolette sono una geniale trovata di Aldo Manuzio, il grande tipografo del Cinquecento, per mettere in evidenza le parti più notevoli dei testi a stampa. Anche il bambino impara con difficoltà i segni di interpunzione.Una nota psicologa dell'infanzia, Emilia Ferreiro, messicana, ha mostrato che i bambini oscillano soprattutto nell'uso delle virgole (che tendono a far coincidere con le pause di respiro) e dei punti (a cui danno valori speciali). A volte ad esempio mettono il punto quando passano dal discorso indiretto a quello diretto. Il fatto è che la punteggiatura incorpora una gran massa di teoria, e per questo non si può improvvisare. Non basta dire, come faceva la maestra, che il punto va messo quando «il pensiero è completo». Nessuno sa davvero quando il pensiero è davvero completo! Inoltre l'italiano, a differenza dell'inglese, tende ad avere una punteggiatura fitta, e quindi più complicata. La virgola, ad esempio, non sempre riproduce le pause di respiro (fa anche questo, certo: in una elencazione, dopo ogni elemento elencato ci vorrà una virgola), ma spesso descrive la struttura della frase. Un inciso, essendo una frase inserita in un'altra frase, sarà delimitato da due virgole: una che lo apre e una che lo chiude. Spessissimo invece, anche in scrittori esperti, si trova la virgola "che apre" ma non quella che chiude. Ci sono poi le virgole parassite, come quella che anche le persone esperte mettono tra il soggetto e il predicato («L'automobile di mio padre, è piccola e rossa»). Usare l'interpunzione è difficile, ma ciò non giustifica certo il graduale indebolirsi di questa fondamentale risorsa (quasi un bene culturale). La crisi della punteggiatura segnalata da Castellani Pollidori è l'ennesimo segno, microscopico ma allarmante come una fessura nel muro, dell'ulteriore annacquarsi di quella cultura popolare diffusa a cui il primo mezzo secolo di storia dell'Italia moderna ha dedicato tanti sforzi.
|